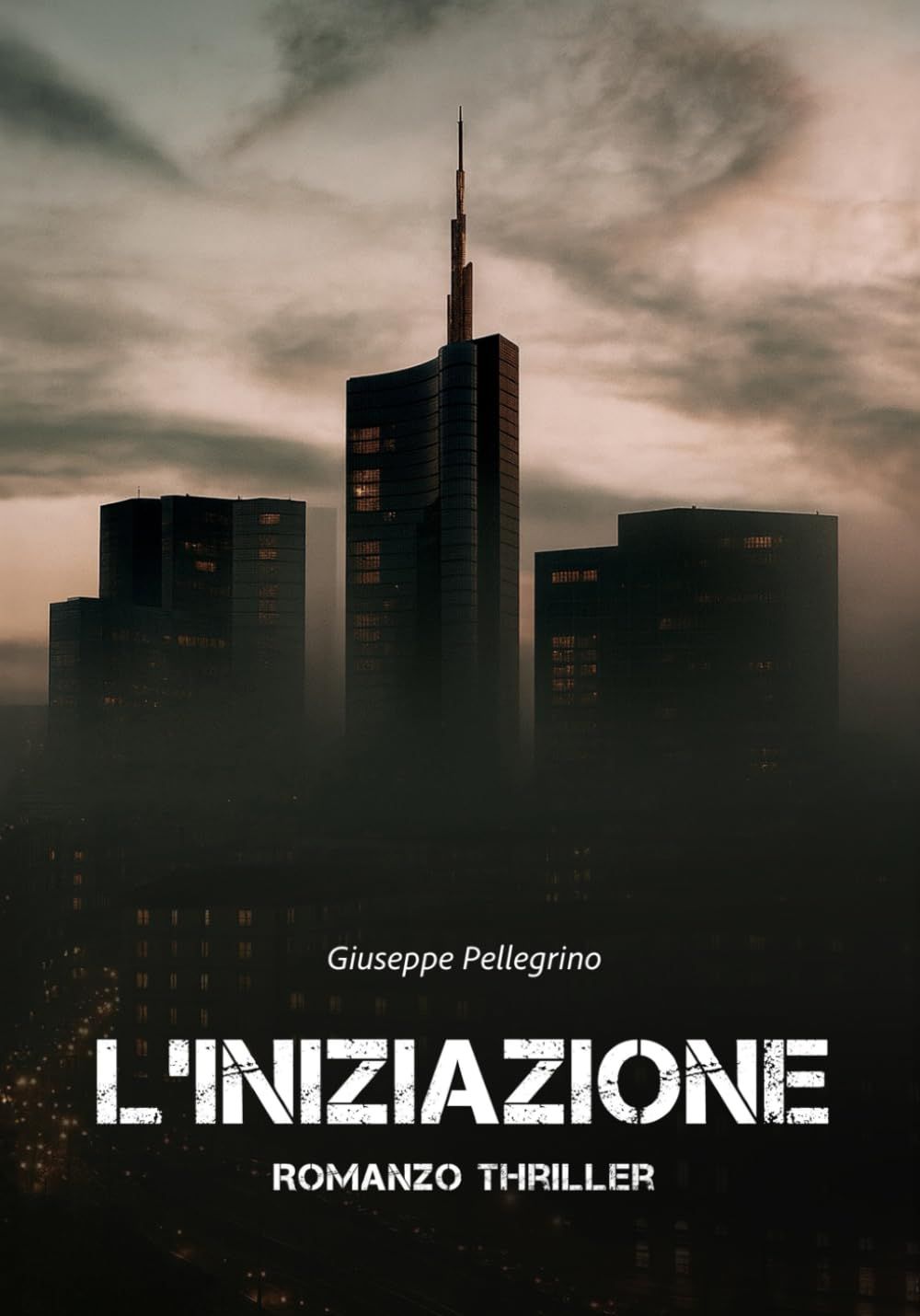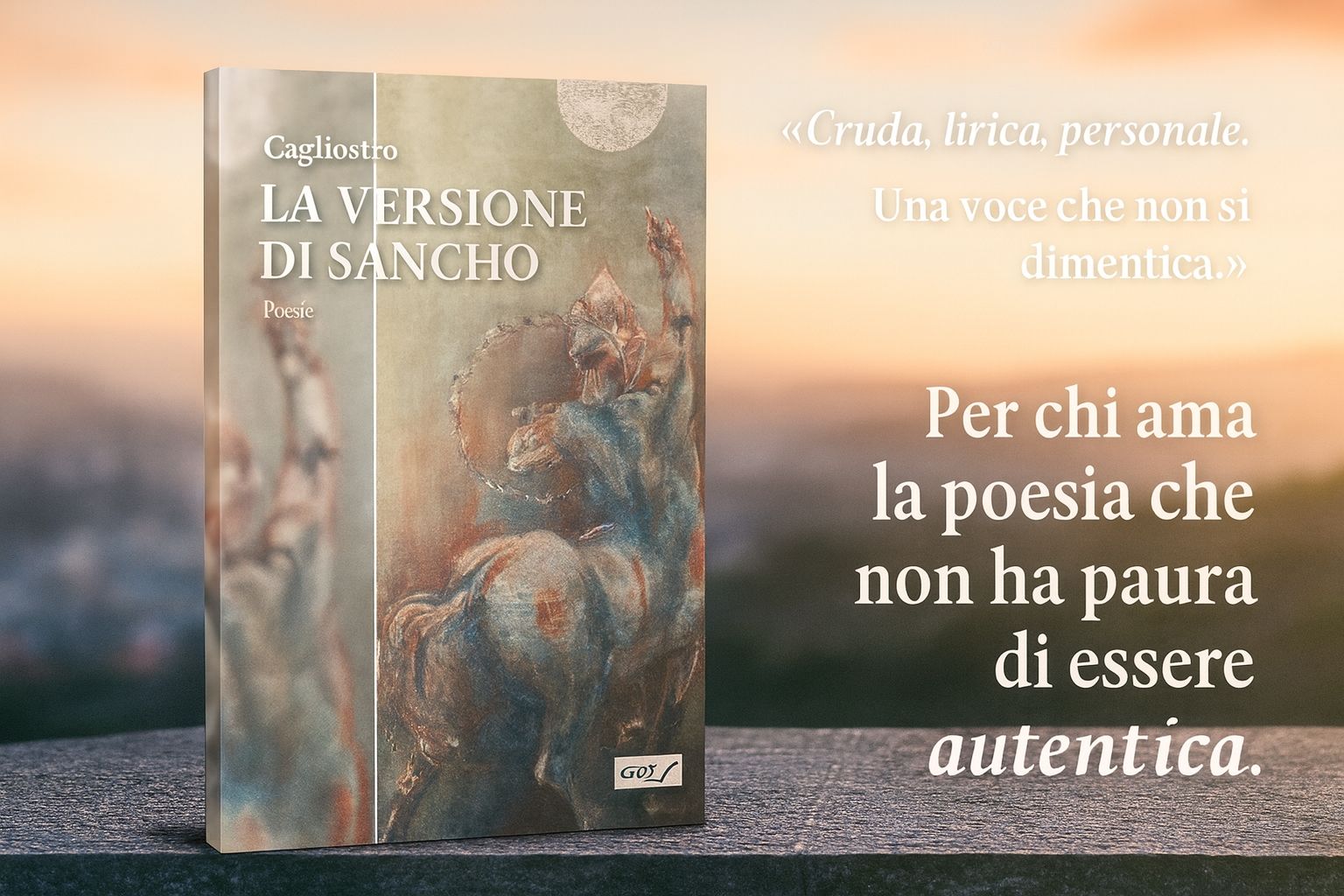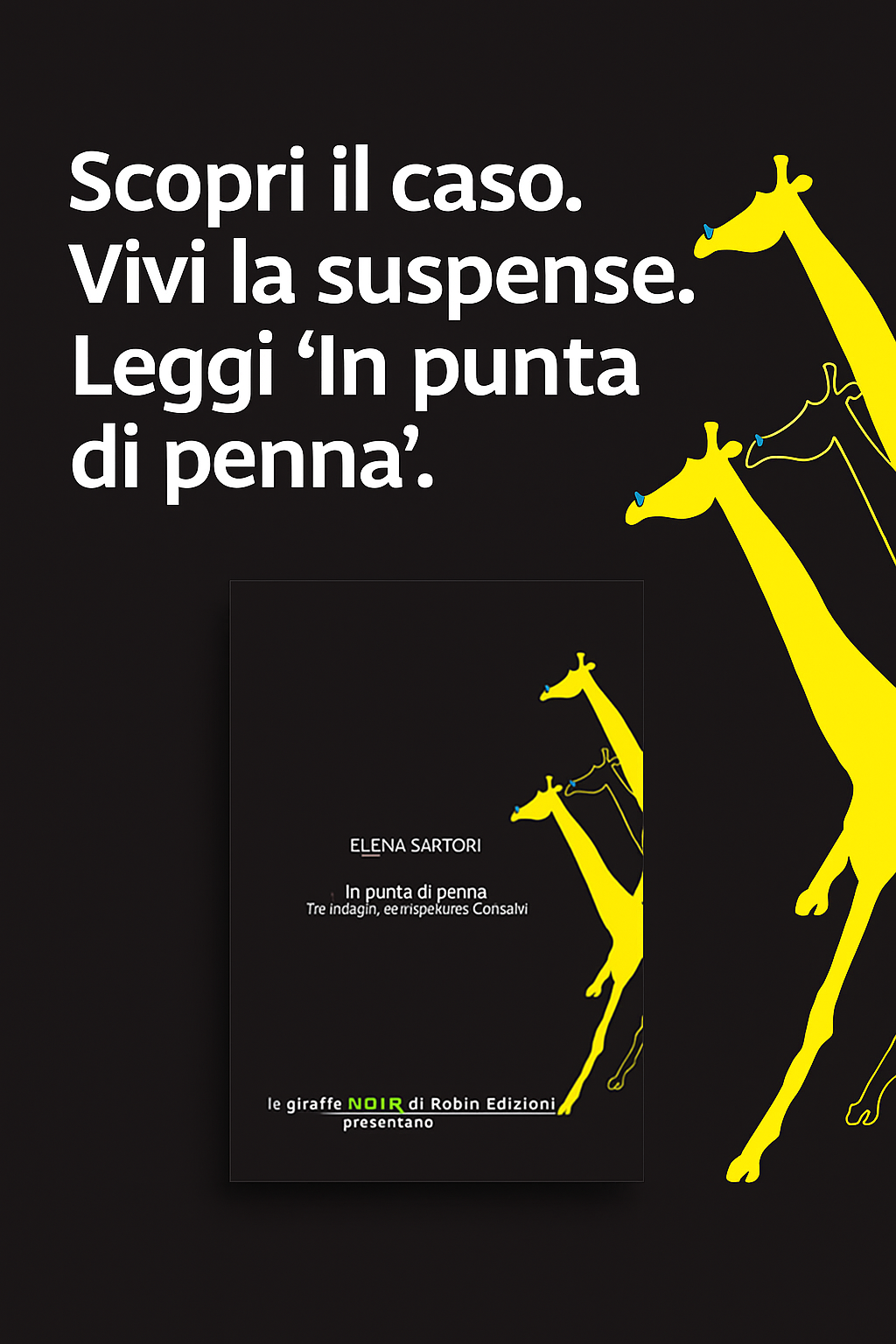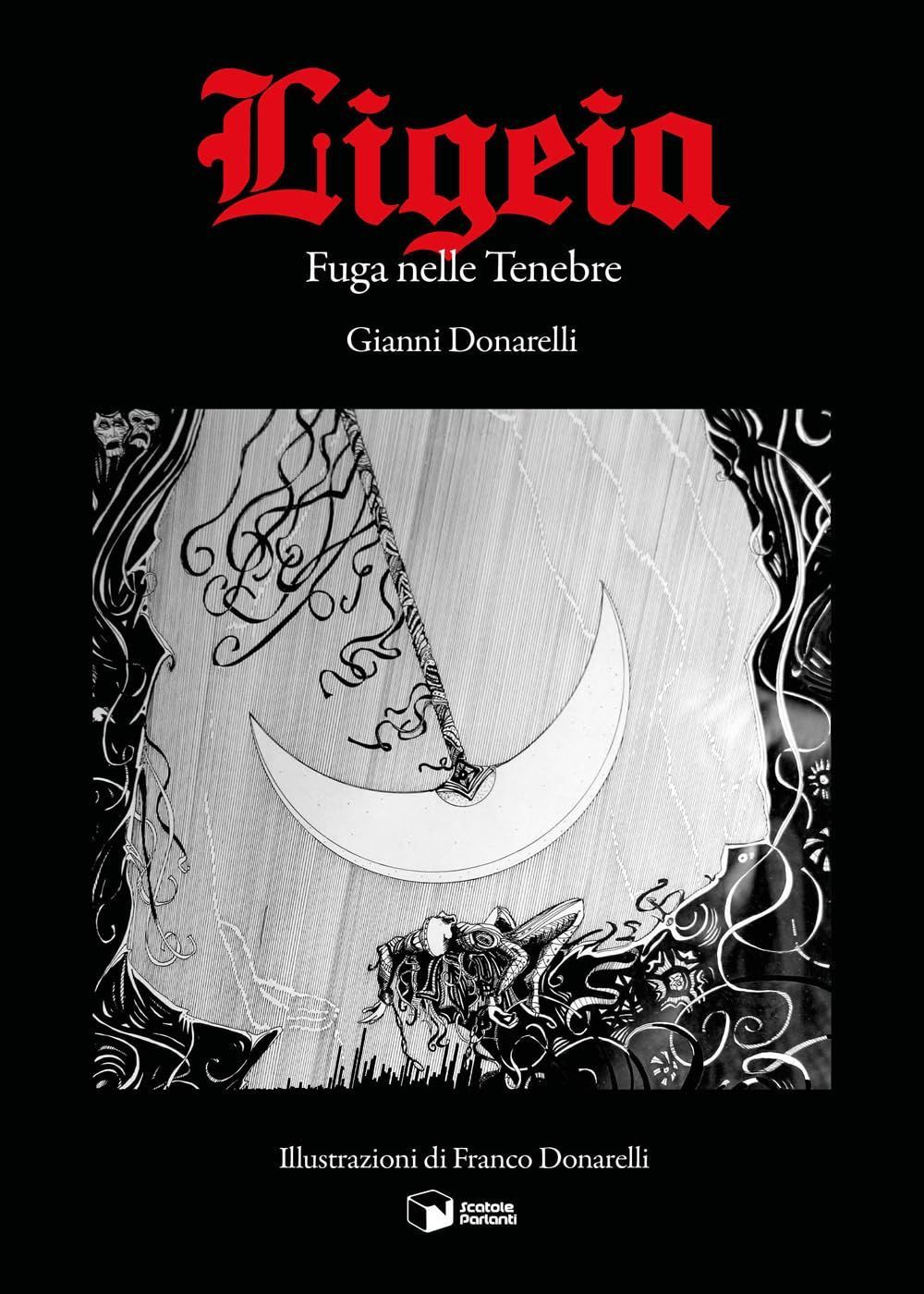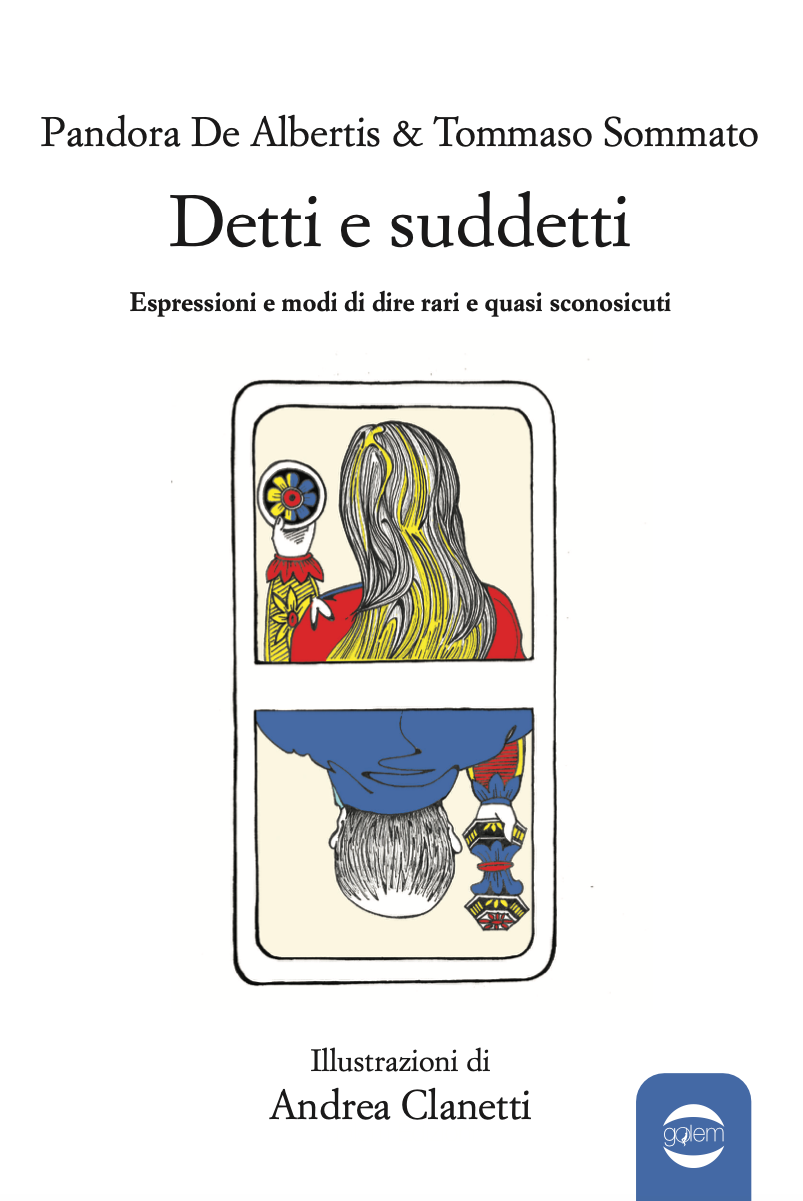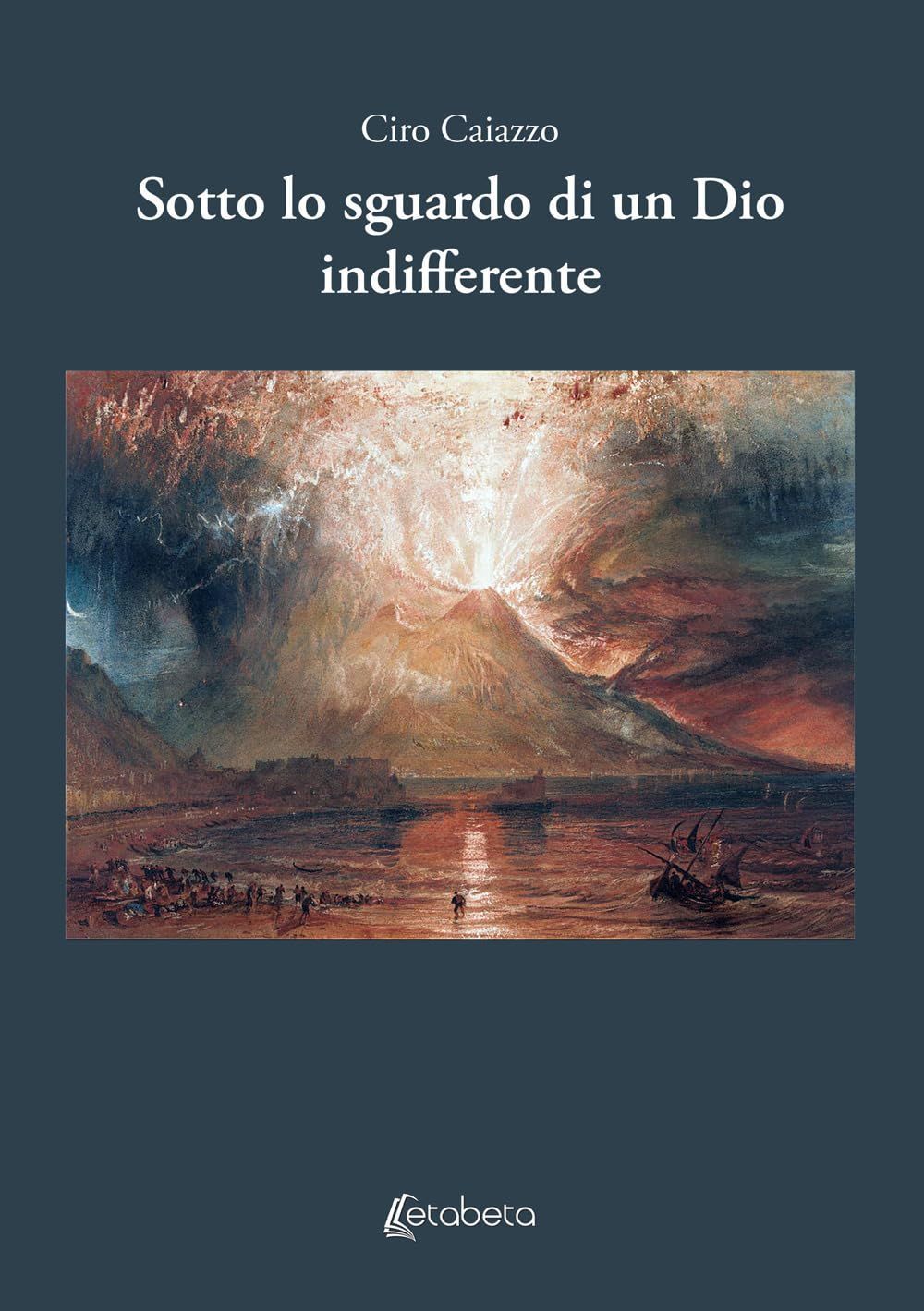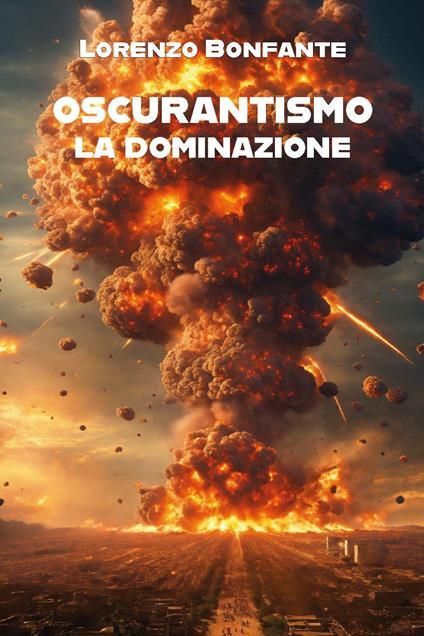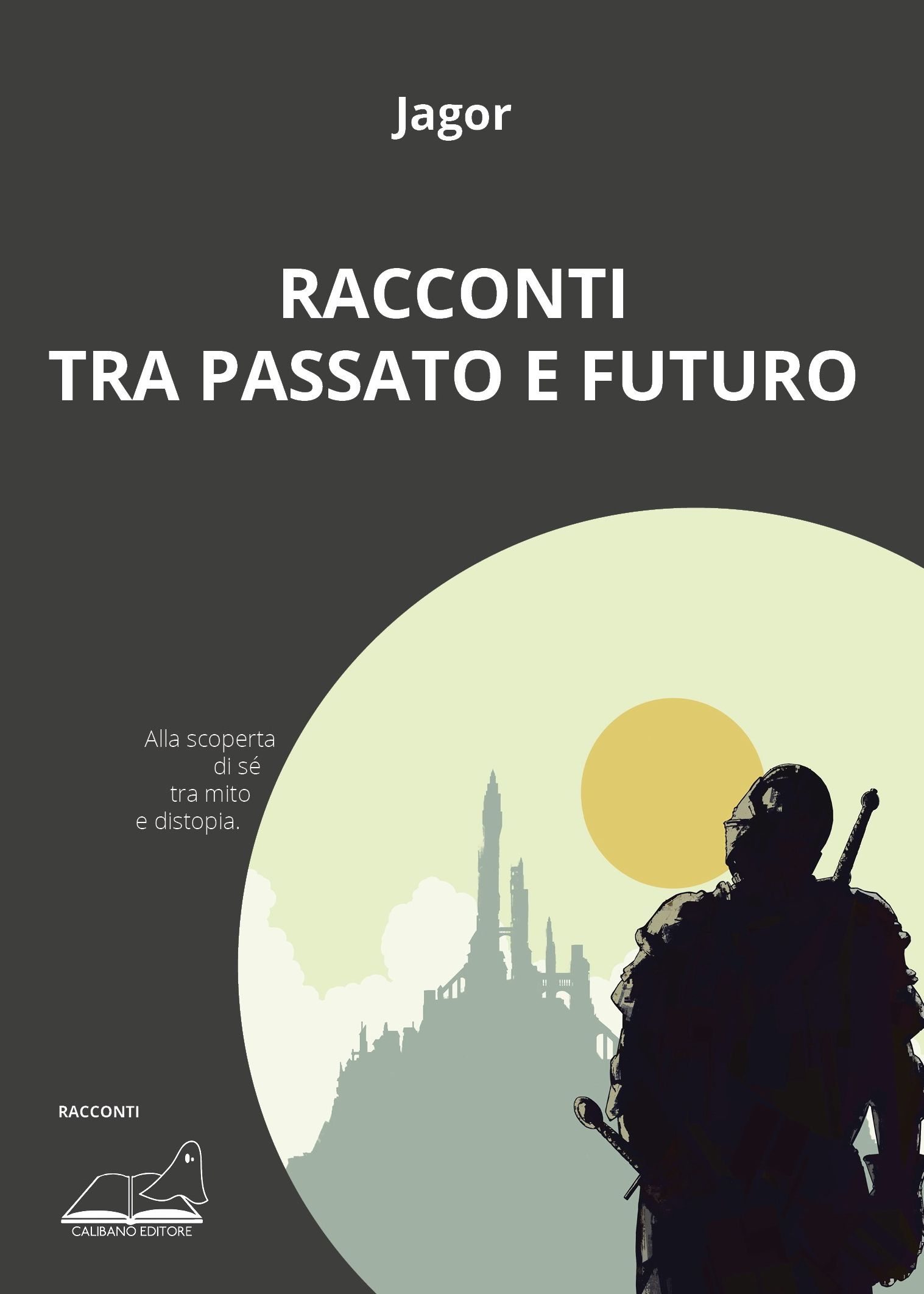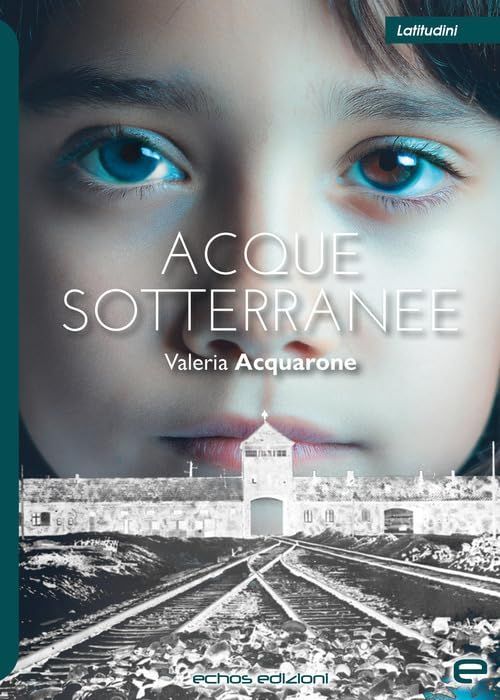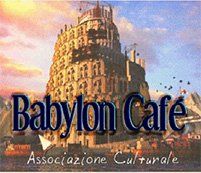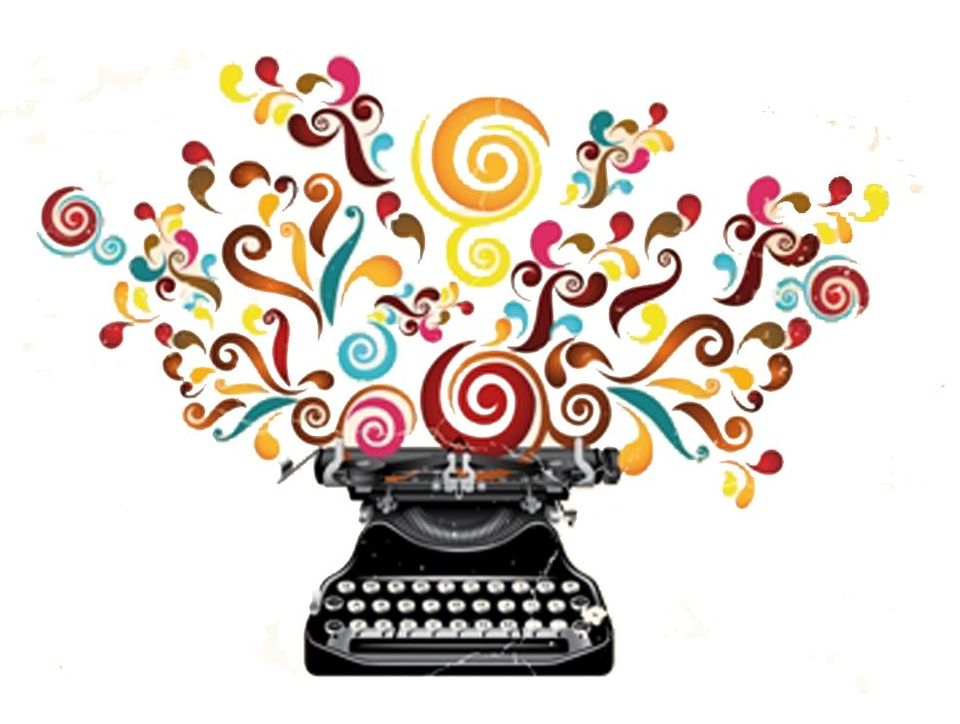Corso base di scrittura creativa - QUARTA LEZIONE
“Lo scrivere è un ozio affancendato.”
(Johann Wolfgang Goethe)
L’ambientazione geografica e temporale di una storia.
Dopo esserci soffermati sull’importanza di saper tratteggiare con la punta affilata della nostra penna, o con quella smussata del cursore del nostro pc, una valida descrizione di un ambiente circoscritto come quello di una stanza, allarghiamo il grandangolo della nostra macchina fotografica ed ampliamo il nostro raggio d’azione.
Una delle caratteristiche salienti che contraddistinguono una storia è la sua ambientazione, sia geografica che cronologica. Ambientare una storia d’amore nei primi anni ’20, ad esempio, darà al nostro racconto una connotazione decisamente diversa rispetto alla scelta di uno scenario metropolitano di una città contemporanea, ma questo è intuitivo. Parimenti alla scelta temporale, quella geografica imprimerà alla vicenda che stiamo narrando un’impronta diversa a seconda del teatro che sceglieremo per far recitare i nostri attori, i protagonisti del nostro racconto. Trattandosi di un corso di base di scrittura creativa, eviterò di complicarti la vita (quello, sono sicuro, sei già bravissimo a farlo da solo!) invitandoti a concentrare la tua attenzione su qualcosa di più abbordabile: un luogo contemporaneo e usuale.
Prima di addentrarci nella descrizione di un luogo, vediamo di chiarire alcuni aspetti salienti della fase di ambientazione di uno scritto. Come sottolineato nella lezione precedente, una delle doti che maggiormente uno scrittore ha bisogno di affinare e di tenere in continuo allenamento è la capacità di osservazione. Capacità che alimenta la creatività e l’ispirazione. Per rendere coinvolgente, quindi verosimile, una storia è utile che lo scrittore abbia dimestichezza, conoscenza diretta, del luogo che farà da palcoscenico alla sua rappresentazione. Ambientare un intrigo internazionale, con tanto di infuocata e bollente storiaccia di sesso e passione, nella cornice incantata degli Champs-Elysées è di sicuro effetto, a patto di conoscere bene la capitale della patria delle baguette, senza creare confusioni tra il quartiere latino e Montmartre. E far ritrovare un cadavere mutilato e straziato davanti alla vetrina di Tiffany nella Fifth Avenue fa molto Alfred Hitchcock, ma richiede una buona conoscenza degli incroci e delle vie principali della Grande Mela. Anche se tu sei un attento e puntiglioso giramondo che rammenta con pedante precisione l’esatta ubicazione delle strade e delle piazze che hai visitato nella tua lunga carriera di girovago, è probabile che il tuo futuro lettore non si sia mai avventurato oltre la spiaggia assolata di Ostia e che poco, o nulla, sappia di posti lontani od esotici, e quindi non si identifichi affatto nella descrizione di una città aliena, lontana e straniera. Inoltre è molto più semplice per uno scrittore, specialmente alle prime armi, confrontarsi con una città in cui vive, o nella quale ha vissuto, e di cui conosce i ritmi, le abitudini, le voci, i colori, il dialetto ed i profumi. Se, invece, sei un appassionato di fantasy, mystery, sci-fi o horror e le ambientazioni dei tuoi scritti sono il frutto della tua immaginazione, allora il discorso cambia radicalmente. Nell’universo governato dalla fantasia tutto è possibile, tutto può essere plausibile e reale, sei libero di dar forma a qualunque costruzione, ambientazione, città sospesa fra le nuvole o castello stregato, l’importante è che il luogo partorito dal tuo estro abbia una struttura stabile, priva di contraddizioni e ben delineata. A tal proposito posso consigliarti di disegnare (basta uno schizzo da bimbo di quinta elementare dotato di poco talento!) una rudimentale mappa della tua città fantastica, dove segnerai i nomi delle strade e la posizione dei palazzi che hai creato, una sorta di cartina topografica, che potrai consultare mano a mano che procederai nella stesura del tuo scritto, in modo da avere un punto di riferimento concreto e non incorrere in contraddizioni narrative. Ma ora torniamo a concentrarci sulle scelta di ambientare un racconto in una città reale, esistente, e facciamo un esempio di descrizione per rendere un po’ più chiaro il discorso che ti facevo appena qualche riga più su:
“Roma è una città d’arte. Il centro storico annovera palazzi seicenteschi e nuove costruzioni che si snodano lungo le vie del centro sempre affollate di passanti e turisti. Il Tevere la taglia quasi a metà e la cupola di San Pietro sovrasta la città osservandola con paziente distacco.”
Questa è la descrizione che chiunque potrebbe fare della città eterna. Riproviamoci:
“Roma è una città complessa, ricca di contraddizioni. Si stende come una matrona pigra adagiata su sette colli, signora d’altri tempi, svampita bionda metropolitana. Il centro storico, come una clessidra dove la sabbia sembra non scorrere più, si snoda da Piazza del Popolo fino a Piazza Venezia, passando per via Colonna, Piazza di Spagna, Largo delle Quattro Fontane e Piazza Navona. Le sue strade lastricate di ciottoli sono un continuo fluire di volti di etnie diverse. Sono percorse da migliaia di affaccendati e frettolosi turisti che scattano foto, fanno la fila davanti alle carrozzelle parcheggiate davanti alla Barcaccia, ansiosi di portare via un souvenir della sua eterna bellezza. Ma Roma è anche borgate, periferie chiassose, sconosciute anche agli stessi romani, che si estendono per chilometri, popolate di gente variopinta, rumorosa, imbottigliata nel traffico caotico. Roma è la città degli artisti di via Margutta e dei vu cumprà che affollano i marciapiedi di Via dei Fori Imperiali, degli orientali che hanno fatto di Piazza Vittorio la loro seconda patria e dei finti centurioni che, armatura in spalla e Nike ai piedi, tentano di divertire le nutrite comitive dagli occhi a mandorla. Il Tevere scorre silenzioso osservando da millenni il mutare delle mode e degli eventi e la Croce sulla sommità della cupola di San Pietro veglia sui fedeli con bonaria ed illimitata pazienza.”
Noti la differenza fra le due descrizioni? Ho volutamente posto l’accento sulle contraddizioni che animano la Capitale. Se ti avessi descritto solo la bellezza dei monumenti te l’avrei fatta apparire come un’incantevole culla di antichità. Se, al contrario, avessi posto l’accento solo sul traffico o sul numero imbarazzante di clandestini che vi abitano, ti avrei trasmesso l’immagine di una città ostile e poco sicura. Ecco un altro risultato che si può ottenere con una buona descrizione: attirare l‘attenzione del lettore sull’aspetto che più ti interessa di ciò che hai deciso di immortalare con la penna. Esattamente come un bravo regista può far diventare un luogo paradisiaco o tremendamente sinistro solo con l’uso appropriato delle luci e dalla cinepresa, così uno scrittore può regalare ai lettori l’immagine che preferisce della realtà che lo circonda. La descrizione di un luogo, infatti, non deve limitarsi a mero esercizio di stile, ma deve creare un’atmosfera funzionale a ciò che stiamo raccontando. Deve essere, in sostanza, personale, ampiamente soggettiva, deve rappresentare il tuo modo di vedere le cose.